Maurizio Cucchi in “Cronache di poesia del Novecento” e più recentemente nell'introduzione a “Giovanni Giudici. Tutte le poesie” (Oscar Mondadori) scrive che appunto la poesia di Giudici si caratterizza per l'autoironia, la doppiezza (il tema del doppio o del sosia), l'originalità. A livello formale il poeta alterna versi sciolti a quartine e ottave. Dal punto di vista della poetica e dello stile il poeta non si lasciò mai irretire dagli ismi che attraversarono il secolo e spesso diventarono mode culturali e letterarie. Infatti si tenne alla larga dall'ermetismo, dal neorealismo, dalla neoavanguardia, dal neosperimentalismo. Riuscì sempre a essere coerente e fedele a sé stesso, riuscendo anche a ricercare, a rinnovarsi. Giudici entrò in scena nel panorama della poesia italiana per diventarne un protagonista e avendo come interlocutori e amici fedeli grandi letterati del calibro di Ottieri e Fortini (si veda il carteggio). Cucchi rileva anche l'apparente linearità e semplicità di Giudici. Infatti è solo apparente: la poesia di Giudici dal tono dimesso si gioca su diversi registri linguistici e concettuali e il fatto che non sia oscura, criptica, oracolare non significa che sia semplice. È vero che l'essere si dice in molti modi, come scriveva Aristotele, e che il linguaggio dell'essere di solito è oscuro, come scriveva Heidegger. Come scrivevo prima a ogni modo la poesia di Giudici è multistrato, è un grande millefoglie. Non solo ma da questo punto di vista il poeta squarcia il velo, illumina, talvolta con i suoi simboli, talvolta con le sue sentenze. È una poesia quindi che cerca l'essenziale, evitando orpelli inutili, accessori inconsistenti come virtuosismi e leziosismi, ma mai rinunciando alla complessità dell'animo umano e delle cose. È una poesia innanzitutto che, utilizzando la medietà verbale, rende poetico ciò che prima di allora era ritenuto impoetico senza se e senza ma. Inoltre Giudici tocca vette ineguagliabili di lirismo, che esprimono l'insondabilità dell'animo, l'assurdità del vivere, il mistero della morte. La sua poesia è di primo acchito, superficialmente neocrepuscolare, ma analizzata più attentamente è metafisica e ontologica, si interroga sul rapporto tra io, mondo, linguaggio ed essere, come i crepuscolari non fecero mai di fatto. Da questo punto di vista Giudici è un poeta ad alto coefficiente di intellettualità, però privo di intellettualismi, in un mondo poetico, in cui molti fanno l'esatto contrario: si perdono in intellettualismi senza avere intellettualità. La poesia di Giudici, come notano tutti i critici, si basa sulla quotidianità ma senza autocommiserazione e autogogna. Giudici descrive la quotidianità alienata, il minimalismo esistenziale. Qualcuno potrebbe obiettare che il poeta rappresenta quasi fantozzianamente la vita impiegatizia. Se così fosse, Giudici sarebbe datato, come i film di Paolo Villaggio, perché oggi le classi sociali non esistono più e con esse nemmeno la coscienza di classe, gli impiegati oggi sono dei signori rispetto ai tanti disoccupati, sottoccupati, precari a vita, etc etc. No. Non è così. Sarebbe troppo riduttivo e fuorviante. La condizione di impiegato e di piccoloborghese del poeta è la chiave di accesso per il grigiore esistenziale, per il torpore, la noia tout court. La datità storica, economica, sociale diventa elemento astorico e universale, diventa “caro sgomento di esistere”. In Giudici non è presente l'odio di chi è piccoloborghese per estrazione e intellettuale per formazione. In Giudici non c’è la mistura infelice del solito cattocomunismo di quegli anni, fondato su utopie irraggiungibili, spinta rivoluzionaria che diventa legittimazione della violenza, clientelismo, tradizione, invidia per chi ha di più, ma c’è un connubio ben ponderato di socialismo e cattolicesimo, basato principalmente sul senso di colpa per chi ha di meno e sull'umanesimo. Nella sua poesia non c'è senso di supponenza né di superiorità perché il poeta si sente uomo comune, uomo in mezzo agli uomini, pur intravedono molto lucidamente le ombre e non solo le luci del boom, del miracolo economico. Giudici fa una contronarrazione del boom economico e in questo senso compie la stessa operazione, seppur con stile ed esito diverso, del Bianciardi de “La vita agra”. La poesia di Giudici non si fonda sulle sovrastrutture intellettuali, culturali, religiose. Non si fonda sulla struttura economica. Non si fonda sull'infrastruttura psichica. Non si fonda sulla molteplicità fenomenica. Non si fonda sull'ambiguità semantica, che in taluni non diventa mai polisemia vera e propria. Tutte queste cose sono presenti ma nella giusta dose, senza difettare né eccedere, perché il poeta conosceva benissimo il peso specifico di ogni verso che scriveva. La sua poesia è invece basata sul rapporto tra esistere ed essere, ben sapendo, come scrive Bufalino che essere non implica necessariamente esistere e viceversa. In un'epoca in cui l'avere e l'apparire dominano sull'esistere e sull'essere dovrebbero affidarsi in molti alla sua poesia, la poesia di un uomo apparentemente comune con una vita comune ma con il grande dono della parola e non avendo in testa luoghi comuni, che visse, come Montale, al 5%, senza grandi traumi, senza grandi slanci vitali, non abbandonandosi alla tristezza né ai facili entusiasmi. Ma il poeta è importante anche per l'imprendiscibilità e l'irrinunciabilità del dire, che è per lui momento di riflessione e di chiarificazione interiore. Oggi si fa un grande parlare nella comunità poetica del rapporto tra autorialità e autenticità. Ebbene molti dovrebbero prendere esempio dal poeta che era un autore autentico, senza pose e senza infingimenti. Giudici insegna che “essere è più del dire”, ma anche che “talvolta non dire è anche non essere”. Per tutte queste ragioni è uno dei più grandi poeti del Novecento.
- PIÙ RECENTI
-
- Artista dalle molteplici passioni e non solo due lauree e mezzo
- Segrate:Musica di Classe!
- AMORE. Perché nasce, perché vive, perché muore
- Seravezza: Al Caffè della Piazza gli Arrangisti per Plastic Free
- BUSSERO(Mi): LA DONNA è MUSICA… IL TEATRO è DONNA a cura di Massimo Greco
- Quel Qualcosa o Qualcuno che forse ci trascende...
- Sul perché "Il nipote di Rameau" di Diderot è ancora attuale...
- VINO, VERONAFIERE: AL VIA OGGI VINITALY CHENGDU CON 40 AZIENDE ITALIANE
- Gorgonzola: 28 marzo 2025 EVENTO STRAORDINARIO
- Nota sulla poesia di Giovanni Giudici
- 30 giugno 2025 20 giugno 2025 24 maggio 2025 06 maggio 2025 23 aprile 2025 16 aprile 2025 29 marzo 2025 26 marzo 2025 25 marzo 2025 28 febbraio 2025 20 febbraio 2025 10 febbraio 2025 28 gennaio 2025 26 dicembre 2024 23 dicembre 2024
-
Artista dalle molteplici passioni e non solo due lauree e mezzo
- - nessun tag -
- 15:17, 30/06/25
-
Segrate:Musica di Classe!
- - nessun tag -
- 18:23, 20/06/25
-
AMORE. Perché nasce, perché vive, perché muore
- - nessun tag -
- 17:40, 24/05/25
-
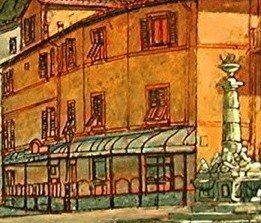
Seravezza: Al Caffè della Piazza gli Arrangisti per Plastic Free
- - nessun tag -
- 18:30, 06/05/25
-
BUSSERO(Mi): LA DONNA è MUSICA… IL TEATRO è DONNA a cura di Massimo Greco
- - nessun tag -
- 11:34, 23/04/25
-
Quel Qualcosa o Qualcuno che forse ci trascende...
- - nessun tag -
- 11:10, 16/04/25
Dalla stessa Categoria
In Evidenza
"Il Post Scriptum" è una testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Verona, al n. 2136/2020 - www.ilpostscriptum.it - Tutti i diritti riservati © Copyright 2019-2023 ilPostScriptum - C.F. MRNNCL90E23L781D. Editing, Marketing & Networking ilPs - P.IVA: 04918110232









