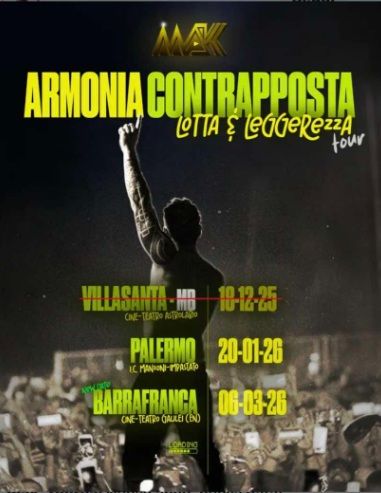Questa non è una presa di posizione.
È una presa di coscienza.
È una lettera che nasce dal bisogno di non distogliere lo sguardo.
Di non anestetizzarsi davanti al dolore.
Di restare presenti, anche da lontano, anche impotenti.
Non si tratta di schierarsi, ma di riconoscere l’umano in ogni volto ferito.
Di continuare a credere che la compassione, oggi, è un atto politico nel senso più nobile: è un gesto che riguarda il mondo che vogliamo abitare.
Ci sono parole che non nascono per spiegare, ma per restare.
Questa è una di quelle.
Scrivo da lontano, ma con l’anima vicina.
Scrivo perché il cuore non sa stare zitto quando l’umanità sanguina.
Scrivo senza schierarmi, perché le lacrime non hanno bandiera.
Scrivo per restare umano — e non dimenticare chi siamo, quando dimentichiamo gli altri.
C’è una terra che chiamiamo Santa, e che da troppo tempo è crocifissa.
Una terra divisa da muri, da razzi, da urla, da vendette travestite da diritto.
Una terra in cui ogni bambino cresce con una sirena nella testa e una pietra nel cuore.
Una terra in cui l’amore non ha il tempo di crescere, e il lutto non ha il tempo di guarire.
Ci dicono che è una questione complessa.
Lo è.
Ma il dolore non è mai complesso.
Un bambino ucciso, una madre amputata, un padre che scava tra le macerie — non hanno bisogno di geopolitica.
Hanno bisogno che qualcuno non distolga lo sguardo.
La memoria che inciampa
Ci dicono sempre di non dimenticare.
Lo scrivono sui monumenti, lo ripetono nelle cerimonie, lo proclamano nei giorni della Memoria.
Ma la verità è che la storia ci boccia, ogni volta.
E noi restiamo asini impenitenti, incapaci di imparare dal sangue.
Lo versiamo, poi piangiamo, poi ricominciamo da capo.
Ed è proprio per questo che, oggi, io non mi vergogno a dirlo: mi sento un asino della
memoria.
Non uno che sa tutto.
Non uno che ha capito.
Ma uno che porta il peso, testardamente, ostinatamente.
Uno che inciampa nei nomi, che si carica addosso storie che non sono sue, che si rifiuta di correre quando il mondo vuole dimenticare in fretta.
Gli asini non hanno un bel passo.
Procedono piano, con le orecchie tese e il cuore saldo.
Non fanno la guerra, ma la strada.
E forse è proprio questo che manca oggi: qualcuno che non commenti, che non urli, che non ceda al bisogno di avere ragione, ma che continui a portare la memoria — anche quando non serve più a niente.
Lettera a chi non si arrende
Questa lettera non è una spiegazione.
È un modo per non spegnere la luce, mentre attorno
il mondo s’incendia.
Un modo per dire che esiste ancora una postura possibile: non l’odio,
non il silenzio, ma la veglia.
Io non so come si costruisce la pace.
Ma so quando inizia a morire: quando ci si abitua alla morte dell’altro.
Quando si pensa che una vita valga meno perché appartiene a un popolo
“nemico”.
Quando si difende la propria ferita negando quella altrui.
Per questo dico: non permettere al dolore di indurirti.
Non cedere alla retorica del nemico.
Non lasciare che la paura ti faccia dimenticare che l’altro è ancora umano, anche se ha un’altra lingua, un altro volto, un’altra memoria.
Essere umani, oggi, significa resistere alla disumanizzazione reciproca.
Non è passività.
È un atto radicale, quasi scandaloso, in tempi come questi.
Una preghiera laica
E allora, a te che stai leggendo, lascio questa preghiera laica: Sii un asino della memoria.
Procedi piano.
Non dimenticare.
Porta nel cuore chi muore, anche se non ha il tuo nome.
E se non puoi fare nulla, non smettere di sentire.
Perché il giorno in cui nessuno sentirà più sarà davvero finita.
E l’umanità — quella vera — avrà perso il suo volto.
A chi non smette di sentire, anche quando non serve più a niente
Ci sono parole che non si dovrebbero scrivere.
Non perché siano proibite, ma perché non bastano mai.
Non bastano a contenere il sangue, le grida, i corpi, le storie che si spezzano ogni giorno in un angolo del mondo chiamato Terra Santa.
Un nome che suona come un paradosso, oggi.
Perché quella terra è tutto, fuorché santa.
È ferita.
È sacra solo nel modo in cui ogni luogo dove si piange diventa sacro.
Tra Palestina e Israele non si combatte soltanto una guerra.
Si consuma una tragedia dell’anima collettiva.
Due popoli, entrambi segnati da una lunga storia di dolore, si fronteggiano da generazioni nel nome della propria giustizia, della propria memoria, del proprio diritto.
Ma in ogni guerra, la giustizia perde.
Non perché non ci sia ragione.
Ma perché, nel momento in cui si uccide, il dolore smette di appartenere solo a una parte.
E comincia ad essere universale.
Il dolore che non sa guarire
Ci sono bambini che non hanno mai conosciuto il silenzio.
Solo sirene, esplosioni, muri, sangue.
Ci sono madri che hanno smesso di sperare perché non hanno più corpi da stringere.
Ci sono uomini che vivono in un perenne “dopo” — dopo l’attacco, dopo la vendetta, dopo l’ennesima sepoltura.
Il dolore, quando è così grande, non ha più nemici da uccidere - Solo se stesso.
L’odio, invece, si tramanda.
Passa come una malattia genetica.
Non perché le persone vogliano odiare, ma perché non hanno mai conosciuto altro.
E allora l’unico modo per sopravvivere sembra quello di trasformare il dolore in rabbia, e la rabbia in giustificazione.
Ma chi ha perso tutto, davvero tutto, non vuole più vincere.
Vuole solo smettere di perdere.
Un altro sguardo
Ciò che serve oggi non è spiegare chi ha ragione.
Serve qualcuno che resti presente dentro il dolore, senza semplificare.
Che non si schieri nel senso di contrapporre, ma che si faccia spazio per il lutto di entrambi.
Che sappia dire:
“La tua sofferenza non annulla la mia.
E la mia non cancella la tua.
Possiamo forse piangere insieme?”
Solo così potrà nascere un tempo diverso.
Non dalla ragione, non dalla politica, ma da un sussulto dell’umano.
Da una compassione che non è passività, ma scelta attiva di non restituire il male.
Una ferita ancora aperta
Questa riflessione non chiede consensi.
Chiede solo silenzio.
Chiede solo di non abituarsi.
Chiede di ricordare che ogni essere umano è, prima di tutto, figlio di qualcuno.
E ogni figlio che muore rende orfano non solo un padre, ma l’umanità intera.