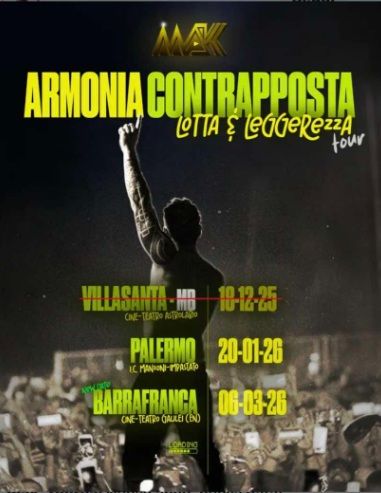}}
Dott.re Carlo D'Angelo, ho letto il discorso di Papa Leone sui Seminaristi ecco la mia riflessione : "Il cuore del seminarista, oggi"
Ci sono stagioni della vita in cui il cuore si fa più inquieto.
Nel tempo del seminario, questo cuore è posto in mezzo a due forze: quella della promessa e quella della prova.
Il seminarista è un uomo in cammino, che ascolta una voce interiore e lascia che questa voce diventi forma, carne, decisione.
Ma oggi più che mai, il cuore rischia la dispersione.
Troppo spesso, infatti, i seminaristi — come tanti altri giovani — si trovano a vivere in un mondo che li forma solo all’efficienza, al rendimento, all’apparenza.
Un mondo che urla, ma non ascolta.
Che connette, ma non accompagna.
E allora, mentre apparentemente “si formano”, rischiano di restare frammentati.
Frammentati dentro, tra paure taciute e maschere indossate.
Frammentati fuori, tra modelli idealizzati e aspettative poco umane.
Eppure — come ha detto Papa Leone con voce chiara e vibrante — il seminario dovrebbe essere una scuola degli affetti.
Non solo un luogo di studio e disciplina, ma una casa in cui imparare ad amare e a lasciarsi amare.
In cui scendere nel cuore e abitarlo, senza paura.
In cui permettere a Dio di entrare non solo nei voti e nelle regole, ma nelle zone più umane, più faticose, più vere.
Il cuore, oggi, non è solo un simbolo poetico.
È il luogo della sintesi: è lì che si combatte la battaglia tra il desiderio e la paura, tra la libertà e il bisogno di compiacere, tra l’amore e il narcisismo.
Non è possibile oggi pensare a un percorso di formazione presbiterale che non parta da questo:
dalla formazione del cuore.
Perché un cuore che non si conosce, che non si ascolta, che non sa distinguere tra ciò che sente e ciò che proietta, diventa un cuore duro, o un cuore finto.
E un sacerdote con un cuore duro o finto, è un uomo solo — anche quando celebra, anche quando predica.
Allora, formare il cuore non è un dettaglio.
È il principio di ogni vocazione vera.
E ogni vocazione non è altro che questo: una storia d’amore da restituire agli altri, nella libertà.
La formazione come esperienza del cuore
Papa Leone è stato chiaro: “Gesù vi chiama anzitutto a vivere un’esperienza di amicizia con Lui e con i compagni di cordata”.
È da qui che parte ogni formazione autentica: da una relazione viva.
Non dallo studio, non dalle regole, non dalle pratiche… ma dalla relazione.
E, prima di tutto, dalla relazione con il proprio cuore.
Formarsi nel cuore significa riscoprirsi amati.
Significa imparare ad amare come Cristo ha amato: con cuore umano, fragile, appassionato, vulnerabile, compassionevole.
Significa accogliere tutto ciò che si agita dentro: la rabbia, la paura, il desiderio, la vergogna — senza respingerli, ma trasfigurarli.
Papa Leone ha detto che “nulla di voi dev’essere scartato”. È un passaggio rivoluzionario.
Significa che Dio non ha bisogno di santi ideali, ma di uomini reali.
Significa che la vocazione non è un’ascesi per pochi, ma una trasformazione per tutti.
La logica del chicco di grano — che muore per portare frutto — vale anche per le emozioni, per le ferite, per la storia personale: nulla va gettato via, ma tutto può diventare seme.
Eppure, quanto spesso nei seminari — e ancor più nei cuori — si fa silenzio su ciò che è umano!
La paura di non essere all’altezza.
La fatica di un corpo che sente.
Il dubbio sulla fede, o sulla propria identità.
La rabbia repressa. Il bisogno di essere visti.
Ma se non si educa l’affettività, essa si vendica.
Se non si educa il cuore, esso si chiude.
E un cuore chiuso non può essere un cuore sacerdotale.
Il cuore sacerdotale non è un cuore perfetto, ma un cuore in cammino, capace di conversione, di tenerezza, di libertà.
È un cuore che non si accontenta di “fare il prete”, ma vuole diventare padre, nel senso più pieno: generativo, presente, non invischiato.
Ecco perché il seminario, oggi, non può essere solo formazione dottrinale:
deve essere formazione integrale.
Una casa dell’interiorità.
Un laboratorio del cuore. Perché “non si può essere pastori secondo il Cuore di Cristo se prima non si è dimorato nel proprio”.
Maturità umana e affettiva: una necessità, non un accessorio
La formazione non è solo un tempo per apprendere contenuti: è un tempo per conoscersi, confrontarsi, lasciarsi cambiare.
E proprio qui si gioca una delle sfide più urgenti della vita seminariale:
la maturità affettiva e relazionale.
Papa Leone lo ha detto con parole nette:
“È importante, anzi necessario, fin dal tempo del Seminario, puntare molto sulla maturazione umana, respingendo ogni mascheramento e ipocrisia.”
Questo significa che il percorso vocazionale non può permettersi scorciatoie.
Non può tollerare zone d’ombra giustificate dalla spiritualità.
Non può nascondere ferite sotto il manto dell’obbedienza.
E non può camuffare immaturità emotiva dietro la dottrina, né rigidità caratteriali sotto la scusa del “carattere forte”.
Un giovane che non si conosce, non può accompagnare altri.
Un giovane che non sa dare nome alla propria tristezza o alla propria rabbia, rischia di usarle — inconsapevolmente — nel ministero.
Un seminarista che non ha imparato a gestire la frustrazione o il senso di inadeguatezza, rischia di diventare un presbitero autoritario, manipolatorio o evitante. Per questo, la maturazione affettiva non è un lusso da psicologi.
È il fondamento del discernimento, della libertà, della fedeltà.
È ciò che rende un uomo capace di amare senza invadere, di guidare senza ferire, di stare senza dominare.
Perché, diciamolo chiaramente:
un prete non maturo è un pericolo per se stesso e per gli altri.
Non perché abbia cattive intenzioni, ma perché non sa quello che porta dentro.
Non sa come agisce il proprio inconscio.
Non sa distinguere un bisogno da una vocazione.
Non sa accogliere una relazione senza confondersi.
Non sa elaborare un dolore senza chiudersi o esplodere.
Ed è qui che torna con forza il richiamo del Papa:
“Se vi prenderete cura del vostro cuore, con i momenti quotidiani di silenzio, meditazione e preghiera, potrete apprendere l’arte del discernimento.”
Discernere significa riconoscere.
E per riconoscere, bisogna sentire.
Sentire i moti del cuore, le emozioni che nascono, i pensieri che ci abitano, le immagini che ci spaventano.
Solo così si può diventare liberi interiormente.
E solo chi è libero, può donarsi.
Gli altri — gli inconsapevoli — finiscono per usare il ministero per coprire il proprio vuoto.
La libertà interiore e la cura delle ferite
Uno dei passaggi più profondi e rivoluzionari dell’intervento di Papa Leone è questo:
“Scendere nel cuore a volte può farci paura, perché in esso ci sono anche delle ferite. Non abbiate paura di prendervene cura, lasciatevi aiutare, perché proprio da quelle ferite nascerà la capacità di stare accanto a coloro che soffrono.”
Qui si gioca tutta la posta in gioco di una vocazione matura.
La vera libertà interiore non è il frutto della forza di volontà, né dell’efficienza spirituale.
È frutto di un lavoro silenzioso, umile, profondo: quello di guardare in faccia la propria storia.
Molti seminaristi — e molti preti — portano dentro di sé ferite antiche:
assenze genitoriali, rifiuti interiorizzati, bisogni non riconosciuti, sentimenti mai nominati.
Ferite che diventano copioni: modi ripetitivi di cercare l’amore, la conferma, il senso.
E se non riconosciamo questi copioni, li replichiamo: nelle relazioni comunitarie, nel modo di vivere l’autorità, nella gestione della solitudine o del potere.
Chi non ha elaborato la propria storia, sarà costretto — spesso inconsciamente — a usare gli altri per guarirsi.
Ma questo non è amore.
E non è nemmeno ministero.
È una richiesta di salvezza mascherata da disponibilità.
È una forma di dipendenza emotiva camuffata da dedizione.
La ferita non elaborata diventa necessità.
E la necessità è incompatibile con la libertà.
E senza libertà interiore, non c’è discernimento.
Non c’è castità.
Non c’è dono.
C’è solo confusione, o — peggio — spiritualizzazione della dipendenza.
Ma la ferita, se vista e custodita, può diventare grazia.
Papa Leone ha detto:
“Proprio da quelle ferite nascerà la capacità di stare accanto a coloro che soffrono.”
È così.
Chi ha pianto davvero può asciugare le lacrime degli altri.
Chi ha attraversato l’inferno con Dio, può portare luce in altri inferni.
Chi ha conosciuto la notte e non si è arreso, diventa custode dell’alba per molti.
Ecco la bellezza di una vocazione integrata:
Non si fonda sull’assenza di problemi, ma sulla presenza dell’amore di Dio dentro la propria storia concreta.
Un seminarista che conosce la propria ferita è un seminarista che sa dove curare.
È un uomo che potrà essere padre senza invischiare, guida senza confondere, amico senza dipendere.
E tutto comincia dal coraggio di dire:
“Questa è la mia storia, e la offro a Dio per essere trasformata.”
V. Un cuore profetico, una formazione abitata
Nel cuore del discorso di Papa Leone ai seminaristi, troviamo un invito chiaro, forte, inedito:
“Non giocate mai al ribasso, non accontentatevi, non siate solo ricettori passivi, ma appassionatevi alla vita sacerdotale, vivendo il presente e guardando al futuro con cuore profetico.”
Parole che non si sentono spesso nei contesti formativi.
Parole che restituiscono dignità al seminarista: non come contenitore da riempire, ma come protagonista del proprio cammino.
Essere profetici, oggi, non significa fare proclami o lottare contro il mondo.
Essere profetici significa abitare con autenticità il presente.
Significa non barattare la propria interiorità con l’immagine esteriore.
Significa rifiutare l’omologazione spirituale per abbracciare la verità della propria umanità.
Un cuore profetico è un cuore sveglio, che non si lascia sedurre dal consenso né dalla rassegnazione.
È un cuore che vede e discerne.
Che si lascia istruire dalla realtà, dalle emozioni, dai volti, dal Vangelo vivo della propria storia.
È il contrario dell’adattamento passivo.
È il contrario del “vado avanti perché ormai ho cominciato”.
È il contrario del “intanto faccio il prete, poi vediamo”.
Formazione abitata significa esserci, davvero.
Nella preghiera e nello studio, nella comunità e nella solitudine, nei colloqui e nei silenzi.
Significa dire: questa vita la scelgo con tutto me stesso, e se c’è qualcosa da curare, da chiarire, da lasciare… lo affronto.
Perché un cuore che ama non cerca scorciatoie.
E un cuore che ama non ha paura della verità.
La formazione, allora, diventa un pellegrinaggio.
Non verso un ruolo, ma verso un’identità pienamente umana e pienamente redenta.
Un percorso che conduce a diventare uomini veri, non funzionari del sacro.
Uomini che conoscono il dolore e lo trasfigurano.
Uomini che non hanno paura di amare con tutto se stessi, nel celibato, nella castità, nella libertà.
Conclusione: il seminario come grembo di umanità nuova
Concludiamo questo cammino con un’immagine semplice e potente:
il seminario come grembo.
Un grembo in cui Dio plasma la vita.
Un grembo in cui le ferite diventano carne risorta.
Un grembo in cui si impara l’amore non perfetto, ma vero.
Un grembo in cui il cuore del seminarista — fragile, pieno di domande, assetato di senso — viene abitato dallo Spirito.
E lì nasce, in silenzio, il prete del futuro:
Non un eroe, ma un uomo.
Non un perfetto, ma un presente.
Non uno che domina, ma uno che accompagna.
Non un immaturo che cerca amore, ma un adulto che lo sa donare.
Che il Signore ci conceda, per la sua misericordia, formatori capaci di vedere i cuori…
…e seminaristi disposti a lasciarsi guardare, per diventare finalmente uomini secondo il Cuore di Cristo.