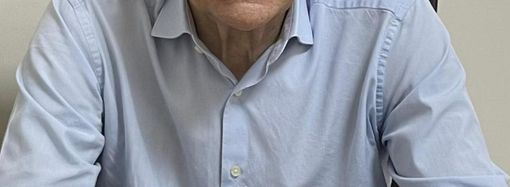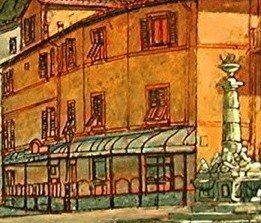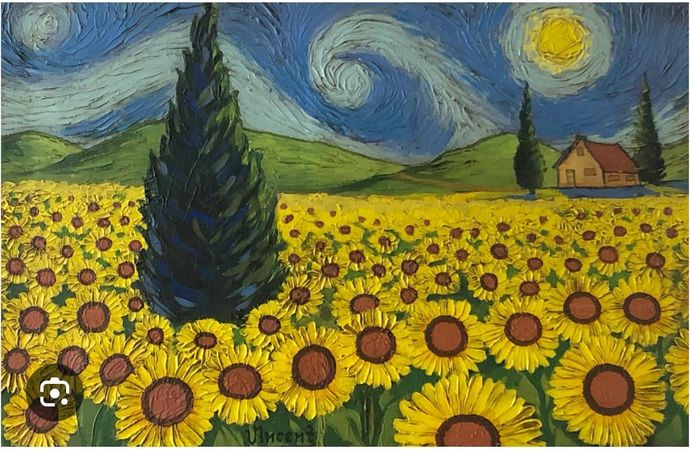In un aforisma il critico letterario, poeta e scrittore Giorgio Linguaglossa scrive che ci sono due categorie di persone: quelle per cui la vita non ha un senso e quelle per cui la vita un senso ce l'ha. Ci sono quindi sostanzialmente persone che vivono la vita in base a un senso e altre in base al nonsenso. Tutto si gioca sul discrimine senso e nonsenso. Nell'arco di ogni vita senso e nonsenso talvolta si alternano. A volte troviamo un senso in un periodo in cui pensavamo che niente avesse senso e viceversa. Diciamo che c'è chi privilegia che la vita abbia un senso e chi il contrario, salvo imprevisti, ripensamenti, tormenti, inquietudini, metamorfosi e metanoie esistenziali.
Da una parte, semplificando, c'è H.Hesse che scriveva che la vita non ha un senso, ma siamo noi che dobbiamo darle un senso, e dall'altra ci sono Heidegger che tratta dell'inautenticità dell'esistenza e il teatro dell'assurdo, che denuncia e rivela l'insensatezza e l'assurdità dell'esistenza.
Per il costruttivismo l'uomo è un ricercatore di senso e di coerenza. Ogni uomo costruisce un senso in base alla sua esperienza. In base a quelli che Kelly chiama costrutti personali anticiperebbe, determinerebbe e interpreterebbe nuovi eventi. In questo senso come non ricordare Nietzsche, secondo cui non esistono fatti ma solo interpretazioni? La mente di un individuo quindi sarebbe una continua sommatoria di interpretazioni coerenti. Come affermava Piaget (1979), “l’intelligenza organizza il mondo organizzando sé stessa”. Però la psicologia contemporanea considera in modo inadeguato il fatto che l'uomo interpreta e dà un senso al mondo, alla vita in base alla metafisica.
Ricercare un senso significa poi alla fine interrogarsi sul “problema del senso dell'essere”, come fece Heidegger in “Essere e tempo”. Sappiamo che l'uomo è un animale ontico, che si interroga sull'essere, che l'essere potrebbe manifestarsi nel linguaggio, ma dobbiamo anche ricordarci che Heidegger non scrisse mai la seconda parte di “Essere e tempo” perché non riuscì a scrivere sull'essere con le parole e le idee della metafisica. Logica, linguaggio, cultura non possono andare oltre. Ogni tanto l'uomo tramite esse intravede la radura. Ma il nichilismo è una boscaglia fittissima, inestricabile. Ci vorrebbe quindi forse una nuova metafisica oppure bisognerebbe rassegnarsi, pensando che ogni metafisica umana si ferma sulla soglia dell'essere, che l'essere è indicibile, che questi sono i limiti intrinseci della natura umana. Non sappiamo ancora se le nostre colonne d'Ercole sono fatte di natura o cultura.
Con il cogito cartesiano “io penso” diventava “io sono”. Ma il soggetto cartesiano è stato spodestato. Siamo tornati a “io mento” di Epimenide. “L'io non è padrone a casa propria” per Freud. Noi non siamo padroni del nostro pensiero. Inoltre non si sa più se i pensieri siano davvero nostri o del potere incarnato dalle sovrastrutture culturali, dai mass media, dalla televisione. La nostra soggettività è ridotta, nonostante la nostra libertà d'azione sia aumentata. Ciò che viene imposto e propinato dal potere ci sembra oggettivo e vero (“è vero perché l'hanno detto alla televisione “).
Ogni paradosso è un cortocircuito della nostra logica e i paradossi spuntano a bizzeffe. Ma i paradossi peggiori sono quelli delle nostre vite. La Storia non può essere maestra di vita, come ci insegnano le critiche allo storicismo. E l'arte? Per alcuni filosofi come Vattimo l'arte, la letteratura non dicono niente di più sul mondo, non danno apporto di conoscenza, sono solo espressione di stati d'animo. L'arte quindi non aggiungerebbe nessun tassello al mosaico della conoscenza in una cultura il cui il pensiero si è fatto debole, anzi debolissimo. Per Heidegger l'arte apriva mondi, era “la messa in opera della verità”. Come ci ricorda Gadamer cosa sarebbe la Provenza senza Van Gogh e Cézanne? E “Se questo è un uomo” di Primo Levi non racconta e descrive il lager meglio di tanti libri di storia? E cosa sarebbe lo studio del nichilismo senza Dostoevskij e Turgenev? E J.Roth con i suoi romanzi non ha rappresentato meglio di qualsiasi storico e sociologo la condizione degli ebrei orientali e la fine dell'impero asburgico? Ma oggi l'orrore del mondo è rappresentato solo dai mass media. L'arte è considerata solo pura soggettività. L'unica verità è quella oggettiva, quella della scienza. Secondo il decostruzionismo ogni segno oltre ad essere arbitrario è anche indecidibile e rinvia ad altri segni. Noi siamo obbligati a esprimerci e pensare con i segni. I pensieri, il linguaggio, la cultura sono colmi di contraddizioni, aporie, errori. Noi fraintendiamo perciò i segni, il mondo, il nostro stesso pensiero, noi stessi. Il significato è inattingibile. Noi fraintendiamo noi stessi. Ancora una volta “io mento”. La verità non è possibile. Noi comunque abbiamo il compito di cercare un senso, la verità, la bellezza, a forza di distruggere e ricreare, a forza di fare come Penelope che fa e disfa la tela, a forza di fare come Sisifo, ripreso proprio da Camus, guarda caso.